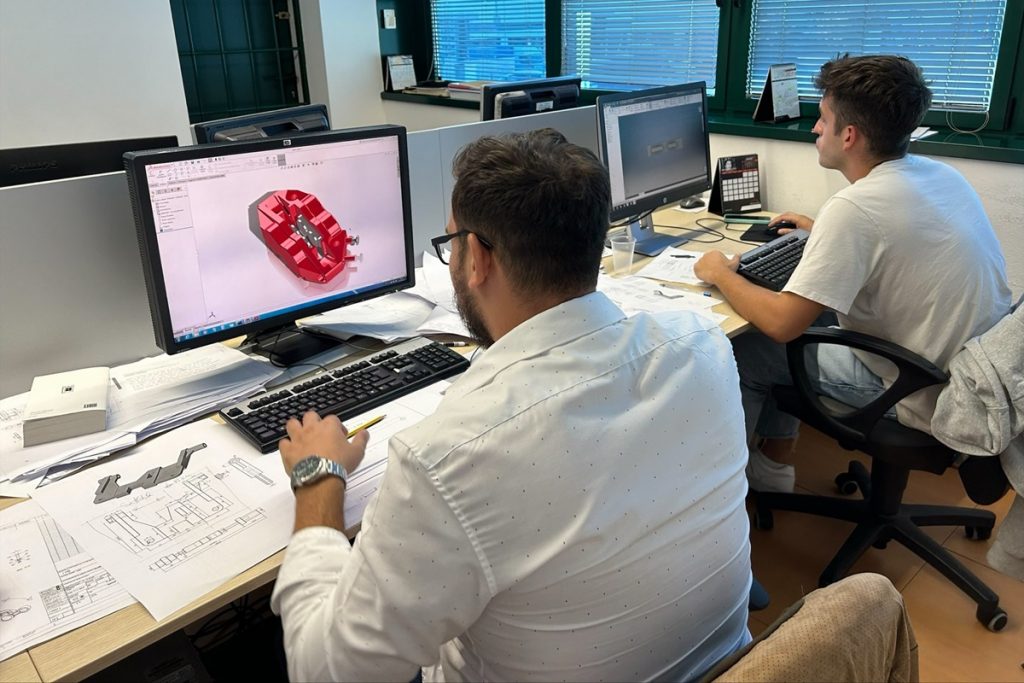Cambiare il posto di lavoro, quali rischi per l’imprenditore
“All things must pass
all things must pass away
all things must pass
none of life’s strings can last
so, I must be on my way
and face another day”
In questi versi di All things must pass, splendida canzone di George Harrison del 1970, si può ritrovare l’essenza del problema di cui ci si occuperà nel presente articolo, cioè quello del trasferimento del lavoratore.
Sì, perché nella vita di un lavoratore subordinato, tra tutte le cose potenzialmente transeunti, va annoverato pure il luogo di lavoro, che può costituire oggetto di cambiamento, anche a prescindere dal consenso del dipendente stesso e dagli effetti psicologici, sociali, familiari ed economici che ne possono conseguire con riferimento alla sua persona o al contesto relazionale-affettivo che lo circonda.
In pratica, quando si accetta di stipulare un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo indeterminato (cioè nella sua forma apparentemente più solida, stabile e tutelante per la parte più debole del rapporto, per l’appunto il lavoratore), bisogna ricordare che, ex art. 2094 del Codice civile, la prestazione lavorativa che ne forma oggetto va svolta “alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro” e che il connesso dovere di conformarsi alle indicazioni operative datoriali ricomprende non solo il ‘come’, ma anche il ‘dove’ tale prestazione vada resa, non potendo confidare, quindi, su una sorta di ‘immutabilità logistica’ del luogo di lavoro definito all’inizio del rapporto.
Va infatti considerata l’assenza di precise indicazioni nella Costituzione che impongano la condivisione con il lavoratore del luogo in cui deve prestare la propria opera e, allo stesso modo, l’impossibilità di desumere automaticamente – da altre disposizioni di carattere generale ivi contenute – la sussistenza in capo al medesimo di un ‘diritto’ a lavorare costantemente solo ove egli dovesse gradire di farlo.
A prescindere, invece, dall’articolo del Codice civile indicato, la disciplina codicistica presenta, nel suo sviluppo logico generale, una successione di norme dalle quali si può automaticamente desumere, in linea di principio generale, l’assunto esattamente opposto.
Infatti, l’art. 2082 definisce come imprenditore colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata” (e quest’ultimo aggettivo è da intendersi in tutti i suoi aspetti, proprio dall’imprenditore medesimo), mentre il successivo art. 2086, ora specificamente titolato Gestione dell’impresa – a seguito dell’art. 375, comma 1 del D.lgs 14/2019 – sottolinea senza alcun dubbio che, per quanto molto tempo sia passato dal 1942, l’imprenditore “è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”, mantenendo quindi una sorta di logica ‘militaresca’, in base alla quale il lavoratore è, sotto alcuni profili, sostanzialmente un ‘soldato’ che deve obbedire al ‘generale’ – o ai suoi collaboratori comunque sovraordinati – in primis per quanto riguarda un aspetto fondamentale delle prestazioni lavorative, richiamata dall’art. 2104: la diligenza.
È pertanto nel succitato art. 2086 che può rinvenirsi la fonte primaria del potere datoriale, come capo dell’impresa, di intervenire sul luogo della prestazione anche modificando definitivamente la sede lavorativa, che differenzia l’istituto giuridico del trasferimento da quello della trasferta (caratterizzata invece dall’intrinseca temporaneità dello spostamento).
Ancora diversa è l’ipotesi del distacco, nella quale il mutamento (che anche in questo caso, pur potendo notevolmente prolungarsi, non dev’essere definitivo) riguarda sì il luogo di lavoro, ma solo come conseguenza accessoria di un altro elemento primario: la variazione temporanea del soggetto, effettivamente gestore del potere di indirizzo e controllo della prestazione del dipendente, cioè del datore di lavoro ‘sostanziale’, mentre quello ‘formale’ rimane sempre quello stipulante il contratto di lavoro.
Detta ultima ipotesi è a sua volta ovviamente differente da quella, legalmente a sé stante e dotata di apposita e dettagliata disciplina normativa, della somministrazione di lavoro (in staff leasing o a tempo determinato) in cui lo iato datore di lavoro formale-sostanziale avviene sin dall’inizio del rapporto, secondo il ben noto schema trilaterale.
L’agenzia di somministrazione abilitata, infatti, assume il lavoratore e lo invia parallelamente all’utilizzatore, con un mix tra contratto di natura commerciale, stipulato tra agenzia e utilizzatore, e contratto di lavoro subordinato, siglato direttamente tra agenzia e lavoratore da inviare all’utilizzatore.
Trasferimenti interni all’unità produttiva
Se ci fermassimo qui, parrebbe quindi di trovarsi in una situazione in cui sussista un potere ‘sovrano’ e unilaterale del datore di lavoro di trasferire il dipendente dall’unità produttiva alla quale è stato destinato a una qualsiasi altra facente capo al medesimo datore di lavoro.
La pluralità di siffatte unità produttive è in realtà un requisito imprescindibile perché si possa giuridicamente parlare di trasferimento, inconfigurabile invece (almeno secondo dottrina e giurisprudenza assolutamente predominanti) quando lo spostamento avviene tra reparti-uffici diversi all’interno della medesima unità produttiva.
A dire il vero, approfondendo l’analisi, si tratta di un potere non proprio assoluto, ma che trova una qualche forma di temperamento in un altro articolo, successivo, del Codice civile, cioè l’art. 2103, che nell’apposito comma 8 dispone, in senso limitativo che “il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, definizione che è rimasta intatta sino a oggi, nonostante il D.lgs 81/2015 sia pesantemente intervenuto su altri commi, relativi peraltro alla diversa tematica del mutamento di mansioni, altresì connessi anche al trasferimento, ma che non devono necessariamente accompagnarlo.
Con un breve excursus storico va peraltro rammentato che la formulazione del sopra citato comma 8 dell’art. 2103 non era affatto contenuta nell’originaria versione del Codice civile del 1942, ma vi è stata, per così dire, innestata dallo Statuto dei lavoratori del 1970 (coevo, quindi, per una curiosa coincidenza temporale, alla canzone di George Harrison da cui il presente articolo ha preso l’abbrivio), data la mancanza, nella versione codicistica antecedente, di una normativa analoga, lacuna solo parzialmente colmata dalla contrattazione collettiva di diritto comune (però sprovvista, stante la mancata attuazione dell’art. 39, comma 4 della Costituzione, di un pregnante valore giuridico erga omnes).
Con l’art. 13 dello Statuto dei lavoratori (poi trasfuso appunto nell’art. 2103 del Codice civile) si è quindi provveduto a riequilibrare la situazione a favore del lavoratore, fornendo veste legale specifica almeno a una minima forma di tutela del medesimo, di fronte ad alcuni cambiamenti incidenti su profili rilevanti dell’oggetto del contratto di lavoro, prevedendo che dovessero essere oggettivamente giustificabili come risposta a peculiari e importanti esigenze imprenditoriali, non fittizie.
Ciò in modo da cercare di contemperare al meglio tali esigenze nel rispetto degli interessi del lavoratore pur mantenendo, sul piano meramente concettuale, una posizione di privilegio per la possibilità di garantire all’imprenditore una gestione veramente efficace nella sua attività produttiva e della relativa libertà di organizzarla in modo consono alle mutevoli richieste del mercato.
Esigenze datoriali e indisponibilità del lavoratore
Dopo l’entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, di conseguenza, il focus di dottrina e giurisprudenza si è logicamente spostato sul reale contenuto di alcune definizioni riportate nel comma 8 di cui sopra, con riferimento innanzitutto alla nozione tecnica di unità produttiva e al significato concreto dell’aggettivo “comprovate”, che deve connotare le esigenze che inducono il datore di lavoro a disporre il trasferimento del proprio dipendente.
Il nodo essenziale del ragionamento, a questo punto, diventava quello di poter identificare, a contrario, il residuo ambito di operatività di una legittima ‘indisponibilità’ del lavoratore a trasferirsi, per carenza dei requisiti legali, sui quali poteva correttamente fondarsi l’ordine unilaterale in tal senso del datore e, correlativamente, l’inversa eventuale legittimazione del medesimo a sanzionare disciplinarmente il dipendente (o addirittura arrivare a licenziarlo) per un rifiuto che potesse ritenersi invece una lesione dei suoi doveri di puntuale esecuzione della decisione di trasferimento.
Con riferimento al primo quesito (oltre a rimandare a quanto detto in precedenza sulla non applicabilità dell’art. 2103 al mero trasferimento da reparto a reparto) si può asserire che la linea interpretativa della Cassazione si è focalizzata sull’individuazione dell’unità produttiva, ritenendo tale ogni articolazione autonoma dell’azienda avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, identità a esplicare, in tutto o in parte, l’attività dell’impresa medesima – della quale costituisce una componente organizzativa – connotata da indipendenza tecnica e amministrativa, tali che in essa si possa concludere una frazione dell’attività stessa.
Ovviamente la contrattazione collettiva e aziendale può ancora interagire sull’argomento procedendo a definire una nozione ‘convenzionale’ a questi fini di unità produttiva maggiormente ampia in senso più favorevole al lavoratore (estendendo quindi l’applicabilità dei vincoli desumibili dal comma 8) – mentre potrebbe risultare più discutibile un’azione in direzione contraria (fatta salva la possibilità di valutare la riconducibilità al concetto di contrattazione collettiva in pejus ex art. 8 Legge 148/2011) – oppure introducendo ulteriori elementi di circoscrizione ‘spaziale’ del concetto (per esempio, come accaduto in passato, disciplinando l’applicabilità della norma nell’ambito specifico del cosiddetto ‘comprensorio’).
Più importante ancora, peraltro, pare essere la necessità di comprovare le esigenze datoriali e le modalità con le quali detta prova vada fornita. Sul tema, la giurisprudenza è risultata spesso oscillante, anche se la Cassazione a sezioni unite, anni fa, aveva sposato la tesi secondo la quale sul datore di lavoro non graverebbe un onere preventivo di motivazione del trasferimento, ma solamente quello di dimostrare ex post, in caso di contestazione, l’effettiva sussistenza delle ragioni tecnico-organizzativo-produttive sul quale il medesimo si fonda.
Per quanto concerne, inoltre, la forma da utilizzare per la comunicazione, in assenza di espressa previsione ad hoc della legge circa la forma scritta, spesso hanno provveduto i Contratti collettivi nazionali (Ccnl) a richiederla, come nel caso dell’ultimo dei Chimici-Confindustria.
Circa l’articolazione della motivazione, invece, perché possa essere considerata valida a supportare il trasferimento, la giurisprudenza ha sottolineato che essa debba comunque essere “adeguata ed esauriente” e si è altresì spesso precisato che debba rispondere alla duplice logica di evidenziare chiaramente, nel contempo, il venir meno dell’utilità dell’impiego del lavoratore nel sito di provenienza e, per converso, la sussistenza di una specifica necessità di utilizzo nel sito di destinazione.
In linea di principio, comunque, l’impostazione concettuale della norma non consentirebbe al giudice di indagare sulla bontà-opportunità ex se della scelta del datore di lavoro (in quanto tale valutazione rientra in quella delicata sfera di intangibilità delle determinazioni imprenditoriali tutelata dall’art. 41, comma 1 della Costituzione), bensì soltanto sulla configurabilità di un’accertabile nesso di causa-effetto tra ragioni indicabili a supporto del trasferimento stesso, accompagnata, come sempre, dal principio cardine di dover gestire il contratto di lavoro secondo “correttezza e buona fede” ex artt. 1175-1375.
Quest’ultimo profilo può rivestire un ruolo specifico di rilievo, soprattutto nell’ipotesi in cui si dovesse presentare una situazione di teorica alternativa nella scelta del ‘trasferendo’, tra lavoratori potenzialmente equivalenti sul piano professionale, ferma restando comunque l’inesistenza di un diritto ‘automatico’ di rientro del lavoratore nella sede originaria una volta scemate o terminate le specifiche esigenze di utilizzo nell’unità produttiva di destinazione.
Va notato che tra le esigenze aziendali legittimanti il trasferimento sono ricomprese pure quelle riconducibili a peculiari necessità di formazione-addestramento professionale del lavoratore, in vista magari di una sua futura riutilizzabilità nell’unità produttiva di provenienza.
Un ulteriore problema che si pone è costituito dalla necessità o meno di un adeguato periodo di preavviso tra comunicazione ed effettuazione concreta del trasferimento. A tal proposito, in mancanza di specifico obbligo di legge, provvede solitamente la contrattazione collettiva nazionale, che pure disciplina, a volte, con disposizioni sostitutive del silenzio legislativo, la differente casistica del trasferimento collettivo, intendendo per tale quello che coinvolge una pluralità di dipendenti.
In questo caso, la sussistenza delle comprovate ragioni andrà dimostrata nei confronti di tutti i trasferiti, verificando peraltro a priori il concreto contenuto del Ccnl, perché in alcuni settori (come il Metalmeccanico) sono stati inseriti alcuni vincoli più stringenti a favore dei lavoratori più anziani o di altre tipologie di lavoratori, reputate strutturalmente più deboli, prestando altresì attenzione al fatto che le suddette ragioni possono in molti casi coincidere con quelle che invece obbligherebbero il datore di lavoro ad aprire, ex art. 4, comma 2, Legge 223/91, una procedura di licenziamento collettivo qualora le figure professionali in discussione fossero identificabili con valutazione concettuale preventiva in almeno cinque soggetti nell’arco temporale di 120 giorni.
Trasferimento illegittimo: cosa comporta?
Fermo restando che in caso di contenzioso spetterebbe al datore di lavoro l’onere della prova concernente la fondatezza delle ragioni determinanti il trasferimento, l’attenzione sul tema deve sempre essere massima perché, seppur entro certi termini di decadenza diversi per l’impugnazione stragiudiziale e il vero e proprio successivo ricorso alla magistratura, un trasferimento sanzionato come illegittimo (cui il lavoratore potrebbe peraltro tentare sin dall’inizio, almeno secondo parte della giurisprudenza, di sottrarsi mediante eccezione di inadempimento ex art. 1460), si rivelerebbe un fastidioso boomerang per il datore di lavoro.
In primis la ‘disorganizzazione aziendale’ che di per sé comporterebbe. Infatti sopraggiungerebbe un complessivo effetto negativo sulla scacchiera delle due unità produttive coinvolte, ripristinando di fatto una posizione organizzativamente non più contemplata nella ‘destinante’ e aprendo nel contempo un vuoto improvviso nella ‘destinataria’.
Poi c’è un potenziale danno all’immagine di correttezza e serietà complessiva dell’impresa che comporterebbe un vulnus non facilmente sanabile pure alla fiducia reciproca che deve permanentemente intercorrere tra le parti contraenti.
Vanno infine segnati, per mero richiamo, ulteriori aspetti residuali della materia che hanno spesso affaticato dottrina e giurisprudenza pur se riguardanti casistiche molto ristrette e particolari (quali la trasferibilità di lavoratori appartenenti a categorie protette o che assistano familiari con handicap, viaggiatori e piazzisti, informatori scientifici del farmaco, componenti di organi amministrativi locali), fattispecie che hanno talvolta dato origine a sentenze, soprattutto di merito, in aperto contrasto tra di loro.
Un’ultima indispensabile notazione riguarda invece la peculiarità della tutela prevista dall’art. 22, Legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) e dell’art. 50, comma 2 del D.lgs 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro), secondo i quali per la validità del trasferimento dei dirigenti di R.S.A. (oggi anche di R.S.U.) e degli R.L.S. è necessario il nulla osta preventivo delle associazioni sindacali di appartenenza, sapendo che in caso di violazione di tale procedura è configurabile una condotta antisindacale punibile con il procedimento d’urgenza regolato dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.
In conclusione non solo “tutte le cose devono passare” e quindi anche la sede di operatività di un lavoratore subordinato non può ritenersi ‘sacra e immutabile’, ma, in un certo senso, nella fisiologia (non nella patologia) di un rapporto di lavoro la mobilità del luogo nel quale svolgere la prestazione può rappresentare una situazione se non abituale, non necessariamente eccezionale.
Per sintetizzare questo concetto cade a fagiuolo un’altra canzone del 1970, ma questa volta dei Kinks, che evidenzia molto bene questa sorta di variabilità potenziale e di conseguente incertezza nella navigazione di qualsiasi ‘mare’ dell’esistenza umana, come tale applicabile quindi anche a quello del lavoro.
“And I’m in perpetual motion
and the world below,
doesn’t matter much to me
this time tomorrow, where will be
on a spaceship somewhere
sailing across an empty sea”.
Docente a contratto di Diritto per l’Ingegneria all’Università Luic Carlo Cattaneo di Castellenza. Sulla rivista ESTE Sviluppo&Organizzazione cura la rubrica ‘Gli scenari del lavoro’ in cui analizza le dinamiche complesse del lavoro, innescate da fattori sociali, tecnologici, giuridici e contrattuali.
trasferimento del lavoratore, Statuto dei lavoratori, esigenza datore di lavoro, Trasferimento illegittimo