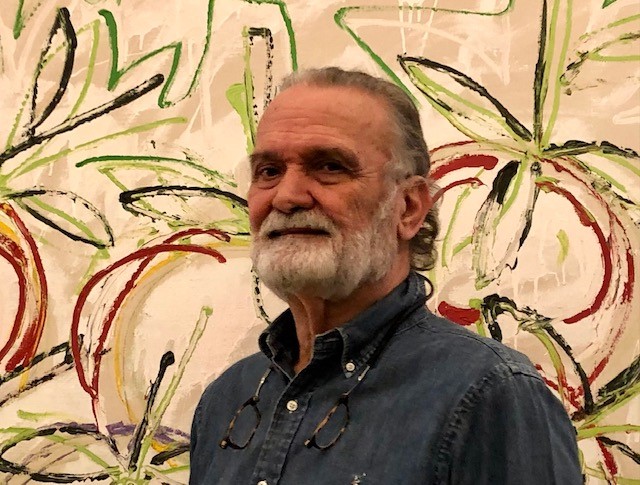E mo’ sono dazi amari
Non si può trattare il tema dei dazi senza capire le ragioni di quanto sta succedendo in termini di contesto, di cause e di correlazione con gli altri parametri economici. Si potrebbe anche semplicemente partire da una banale domanda: perché si parla di “disastro” se il Presidente Usa Donald Trump dice di voler rendere i valori dei dazi “reciproci”? Nessuno può sostenere che la reciprocità sia una cosa ingiusta; certo si può discutere su come calcolare i valori esatti delle reciprocità… È dunque il caso di partire da qui per valutare lo scenario e comprendere se quanto dice la Casa Bianca – l’Europa ha “derubato” gli Usa – sia vero. Alcune informazioni – prese ‘a caso’ fra quelle proposte dai media – pongono tale interrogativo.
Per esempio: perché i formaggi americani sono tassati al 25%, mentre il nostro parmigiano-reggiano era tassato, fino a ieri, solo il 15%? Perché le auto europee erano tassate in Usa solo il 2,5%, mentre quelle statunitensi in Europa subivano la tassa del 10%? Su queste percentuali scattano numerose osservazioni. In effetti sulle merci scambiate e vendute, c’è di mezzo un’altra tassa che gli americani vogliono definire ‘dazio’; mentre noi europei sosteniamo che si tratta di una tassa sul valore aggiunto.
Si tratta dell’Iva che, nonostante sia la “Imposta sul valore aggiunto”, in realtà è una ‘tassa’ che impatta direttamente (e totalmente) anche sul prezzo di vendita dei prodotti statunintensi al consumatore finale. Tale tassa esite infatti anche negli Usa, ma incide (a seconda degli Stati) dal 2,9% al 7,5% (sales tax), mentre da noi dal 10 al 22%. È chiaro quindi che questa tassa incide molto meno sul prezzo di vendita di un’auto europea in Usa che su un’auto americana venduta in Europa. Tuttavia l’Iva non discrimina tra prodotti ‘interni’ e prodotti ‘esterni’ all’Ue, quindi non dovrebbe essere considerata come una tassa sull’importazione.
A Trump, però, fa comodo parlare di tasse, per dimostrare che, alla fine, un prodotto americano che arriva al consumatore fra dazi, Iva e altri costi dovuti alle strette normative europee si trova gravato, probabilmente, di quel 39% che il Presidente Usa ha messo nelle sue tabelle. Non a caso ci propone un dazio del 20%, dichiarandosi “gentile”, in quanto è solo la metà di quello che lui calcola essere invece il dazio da noi applicato (e quindi esclude di fatto lui stesso l’incidenza dell’Iva).
Lo squilibrio della bilancia commerciale
Utile, a questo punto, capire che cosa sia e che cosa non sia il dazio. La comparazione delle tasse di import-export nel mondo è una ‘giungla’ nella quale è difficile districarsi. Questa è, però, una buona occasione anche per fare il punto sulla globalizzazione e sui nuovi rapporti politici-economici tra Usa ed Europa. Iniziamo dall’economia.
Trump sostiene che esiste uno sbilancio import-export tra Washington e Bruxelles di circa 270 miliardi di dollari. Le esportazioni europee verso gli Usa incidono per il 3% del Prodotto interno lordo europeo. Il dato coincide con quello delle esportazioni italiane: occorre dunque sfatare il mito secondo il quale esportiamo in Usa mediamente di più degli altri Paesi. La Casa Bianca considera tale sbilancio a favore dell’Europa come il risultato di politiche economico-finanziarie unfair (traducibile come “non oneste”) usate finora dall’Europa. Inoltre Trump inserisce nel ragionamento il fatto che gli Usa stanno sostenendo la maggior parte delle spese per la difesa europea, attraverso la Nato.
Ma Trump ritiene di doversi ‘rifare’ specialmente nei confronti della Germania, che rappresenta il maggior esportatore europeo negli Usa (quasi tre volte l’Italia) e per la quale Washington rappresenta più del 20% delle sue esportazioni (per l’Italia sono poco più del 10%). La Germania ha un surplus commerciale rispetto agli Usa pari quasi al 50% del valore del suo export e quasi il doppio di quello dell’Italia: è stato calcolato che dal 2002 (anno in cui l’euro ha iniziato il suo corso tedesco) al 2024, Berlino ha accumulato un avanzo commerciale di oltre 2mila miliardi. Ecco: quando Trump dice che l’Europa – specialmente la Germania – è stata “parassita” degli Usa e li ha ‘derubati’, intende principalmente questo (la Casa Bianca accusa anche l’uso della sottovalutazione dell’euro che ha facilitato le esportazioni: è la stessa accusa mossa da Bruxelles di fronte alla ‘rottura’ delle regole di rigore finanziario da parte della Germania per poter risollevare il suo Pil).
Non a caso ora Trump sta ora impostando una politica finalizzata alla riduzione del valore del dollaro per sostenere le esportazioni Usa. Politica dei dazi e svalutazione del dollaro sono azioni sinergiche della politica trumpiana per ridurre il deficit commerciale degli Usa. In realtà esiste una terza linea d’azione sinergica – usata dal Presidente statunitense – cioè trovare il modo di sostenere l’enorme debito pubblico americano attraverso la sottoscrizione dei suoi bond da parte del resto del mondo: il realtà il debito pubblico americano è ‘solo’ il 130% del Pil (quello italiano è addirittura il 136%), ma l’importo del suo valore assoluto è così elevato da necessitare dell’impiego di quasi tutto il risparmio mondiale che si genera in un anno. L’aumento dei dazi è anche un modo di fare pressione agli altri Paesi per fare trattative a riguardo.
Il boomerang della globalizzazione
A queste motivazioni sui dazi, si aggiungono quelle strategico-politiche per un ‘nuovo ordine mondiale’ e quelle sul processo di globalizzazione. Questo fenomeno è stato attivato proprio dagli Usa a fine Anni 80 e sostenuto da quasi tutti i Paesi del mondo occidentale. Dal punto di vista commerciale, la globalizzazione perseguiva la logica del ‘libero mercato globale’: solo così si spiega l’ingresso nella World trade organization (Wto) della Cina nel 2001, storica nemica dell’Occidente.
Il processo di rimozione di buona parte delle ‘barriere commerciali’, realizzato dagli Usa per primi (e in maggior misura), è stato molto veloce (forse troppo) e non regolato (forse troppo). Tutto questo ha generato problemi – non subito visibili – in numerosi Paesi occidentali, non pronti con i loro sistemi economici ad affrontare questa sfida globale nel medio termine. Tra di essi, l’Italia che, mentre riusciva ad aumentare significativamente le sue esportazioni, ha visto fermarsi il suo Pil reale dall’inizio degli Anni 2000. Soprattutto abbiamo iniziato a perdere, da quegli anni, il treno di sviluppo degli altri Paesi europei: il nostro Pil reale è rimasto praticamente stabile (diminuendo addirittura dal 2008 in poi), mentre quello degli altri Stati è aumentato di almeno il 30% (mediamente molto di più).
L’attivare il libero scambio in modo repentino ha significato mettere in concorrenza Paesi con elevato costo del lavoro (è il caso dell’Europa) con quelli a basso costo (per esempio la Cina). Invece di definirla ‘concorrenza sleale’, è stata considerata ‘legale’; inoltre è stato accettato come ‘normale’ far esportare in Europa prodotti cinesi fabbricati da aziende sovvenzionate dallo Stato proprio per invadere i nostri mercati (è il caso attuale delle auto elettriche).
L’Europa paga pegno nel libero mercato
Il grande ‘sconfitto’ della globalizzazione in realtà è stato il Vecchio Continente: nel 1999 Usa ed Europa avevano praticamente la stessa percentuale del pil mondiale (circa il 27% ognuno); in 25 anni il Pil mondiale si è più che triplicato e in questa nuova situazione la quota del Pil Usa è rimasta invariata, mentre quello europeo rappresenta ora il 13,5% (cioè la metà) e sta diminuendo continuamente. Purtroppo all’Europa è bastato veder aumentare le sue finanze e le sue esportazioni (sotto l’indiscussa guida tedesca) e non si è preoccupata di aver perso tutti i treni di sviluppo delle nuove tecnologie e dei nuovi modelli di business: è rimasta ancorata al modello tedesco di fine secolo, basato su una economia manufatturiera e di export di prodotti.
Da rilevare che, come la Germania, anche Giappone e Italia, cioè gli altri due leader mondiali nel manufacturing, hanno registrato il calo del Pil pro capite; la differenza però è che Berlino, ‘in fuorigioco’ nei nuovi business mondiali, almeno ha saputo meglio sfruttare i suoi Paesi fornitori e comunque si è arricchito. E magari ci riuscirà ancora imponendo all’Europa quelle spese in armamenti che le permetteranno di aumentare il suo Pil.
In realtà la globalizzazione è stata (e lo è ancora) molto proficua per i protagonisti del mondo finanziario e del business. Infatti le differenze tra i Paesi e i flussi fisici e finanziari connessi agli scambi (anche con la loro variabilità) sono un redditizio ‘luna park’ per gli speculatori finanziari. Ma il libero scambio, finché l’economia mondiale era basata prevalentemente sulla compra-vendita di prodotti fisici, è stato proficuo anche per le aziende che producevano prodotti di alta gamma, sui quali non esisteva la concorrenza diretta dei Paesi emergenti. È qui che i produttori occidentali sono andati a delocalizzarsi per ridurre i loro costi, ma soprattutto per fare arricchire quelle popolazioni in modo da creare in loro una capacità di acquisto dei loro stessi prodotti e aumentare così i loro fatturati ed esportazioni.
Differenziare le risposte ai dazi Usa
Ora però i nodi sono venuti al pettine e si evidenziano i ‘boomerang’ di tale strategia. In realtà per l’Italia i segnali sono arrivati tempo fa, in quanto i nostri prodotti di alta gamma erano piccole nicchie (per la Germania i volumi erano più elevati). Un esempio dell’impatto della globalizzazione è stato il business degli elettrodomestici: eravamo leader mondiali e ora ci sono rimaste solo poche fabbriche, tenute in piedi per pochi anni, perché poi le nostre aziende sono state acquisite solo per comprarci i brand ed eliminare la concorrenza. Forse aveva ragione chi sosteneva che la globalizzazione e il libero scambio avrebbero dovuto essere attivati in modo graduale per gestire meglio il processo di allineamento delle economie che alla fine si è auto-livellato, a danno di chi aveva quote più alte e a favore degli altri… Tuttavia, il boomerang oggi coinvolge anche la Germania.
Le delocalizzazioni delle nostre fabbriche, infatti, ha generato l’effetto che abbiamo insegnato come a produrre e ora questi Paesi (per esempio la Cina) non hanno più bisogno di noi. Inoltre l’eccesso di regolamentazioni europee ha messo in difficoltà le nostre aziende (le uniche a doverle rispettare) e ha reso la concorrenza dei Paesi emergenti ancora più facile. Inoltre, avendo appreso le nostre tecnologie e facendo innovazione da sole, queste realtà hanno superato tutte le competenze europee e se la giocano con gli Usa. E come se non bastasse, la strategia green europea ha aperto a questi Paesi un’autostrada per le loro esportazioni e di fatto continuiamo a sostenere le loro innovazioni, che generano un ulteriore gap tecnologico a nostro sfavore. Torna quindi il concetto che la globalizzazione (anche quella green) non è stata ben gestita e ora ci sono ‘effetti avversi’ non trascurabili.
I dazi possono essere considerati degli interventi di ‘pronto soccorso’: allevieranno pure i sintomi, ma non rimuoveranno certamente le cause. Ma sono davvero necessari per non fare precipitare gli effetti negativi dell’attuale patologia economica? Gli Usa hanno deciso di adottarli e quindi l’Europa può solo concentrarsi su come trasformare questo problema in opportunità: come limitarne i danni? Servirà una risposta comune? Oppure all’Italia serve una strategia differenziante? Probabilmente dovremmo agire in modo differente, ma in questa fase storica sembra difficile affrontare la questione in modo scevro da ideologie e dai relativi dogmi. Però qualche ragionamento out of the box sarebbe utile…
donald trump, Pil Italia, dazi usa, pil europa