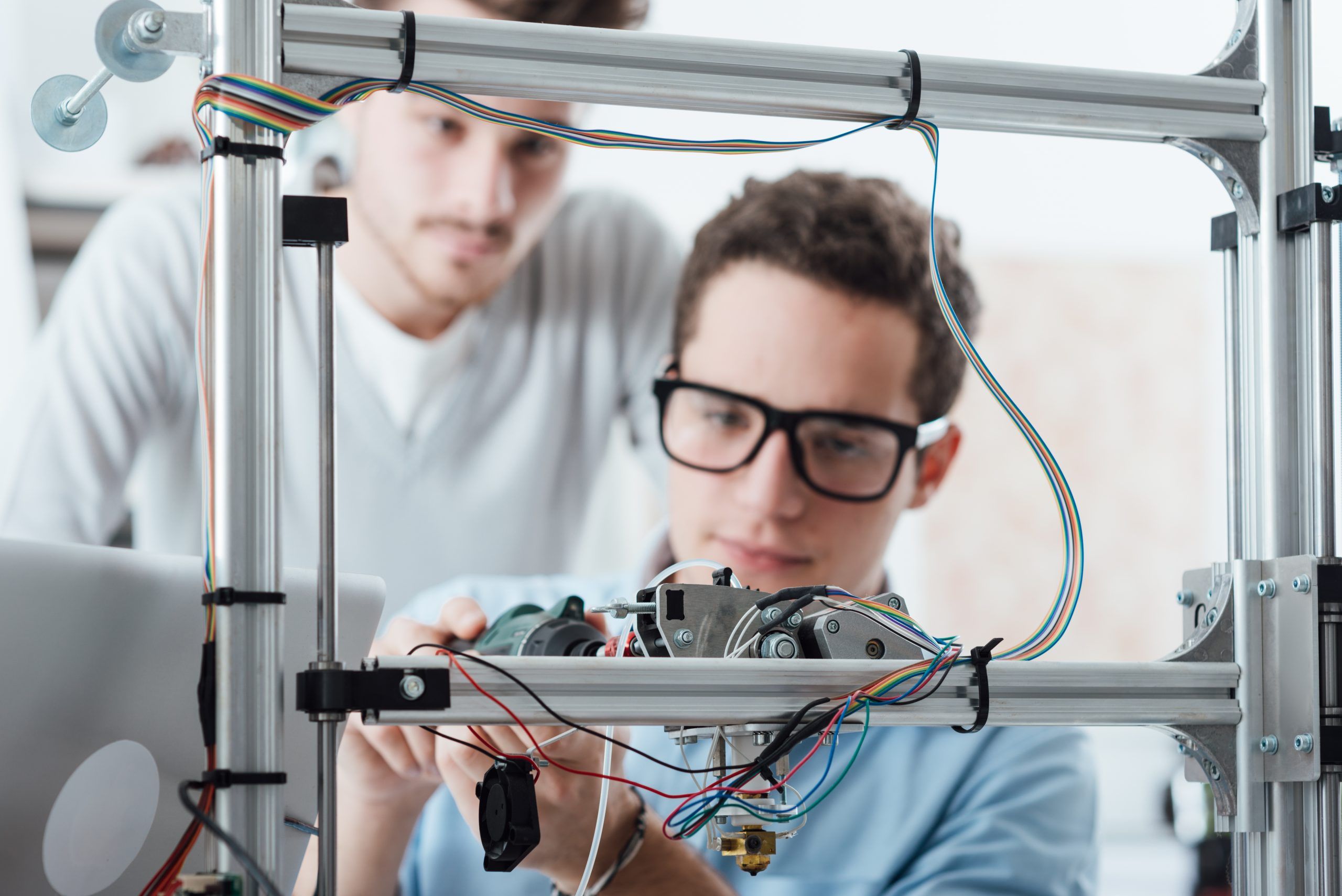
Its, terapia per il crollo della produzione
La produzione industriale è crollata drammaticamente a dicembre per il 23esimo mese consecutivo. Luciano Capone su Il Foglio titola “Il crollo dell’industria fa paura”. E aggiunge che, qualche giorno prima, il Ministro delle imprese sprizzava ottimismo sulla ripartenza della produzione industriale. “La produzione industriale ha ripreso a crescere a dicembre e l’Italia sta facendo meglio di altri paesi europei”, così è riportato. A dicembre invece il calo della produzione industriale è stato del 3,1% rispetto a novembre, e del 7,1% sullo stesso mese del 2023. Il Sole 24Ore scrive che nell’intero 2024 l’indice della produzione industriale ha segnato -3,5%, tornando ai livelli del 2020, in piena epidemia covid 19.
I dati di dicembre sono, indiscutibilmente, assai preoccupanti ed è improbabile che l’Italia abbia fatto meglio degli altri paesi europei, ma sia invece tra i peggiori. È indubbio che i dati pubblicati dall’Istat ci riconducono alla domanda sull’efficacia o addirittura sull’esistenza di una politica industriale del Paese, che di fatto non c’è. È stato anche scritto nel Libro verde prodotto dal Ministero delle imprese, che dovrebbe essere prodromico a un Libro bianco sull’industria, promesso per il corrente mese di febbraio, ma di cui non si hanno notizie. Nel frattempo, abbiamo evidenza dell’assenza di una visione strategica e di investimenti adeguati, con tante altre cose aggiuntive, tra cui la mancanza delle competenze chiave per sostenere l’industria italiana, già messa male di suo a causa della congiuntura economica globale e dalla partecipazione delle proprie aziende in Supply chain dove i driver decisionali appartengono a paesi con economie altrettanto in sofferenza.
Contemporaneamente, ci viene detto che abbiamo raggiunto il più alto tasso di occupazione, ed è vero, ma non è comunque una buona prestazione, perché non si fa osservare che è drammaticamente il più basso in Europa. Ora, che la seconda manifattura in Europa dopo la Germania (ma fino a quando?), abbia raggiunto la più alta occupazione in Italia, rimanendo però la più bassa in Europa, è più una notizia preoccupante che non confortevole. Infatti, il tasso di occupazione influenza direttamente i fattori produttivi e quindi la competitività di un sistema economico. Approfondendo l’anamnesi sul mercato del lavoro, osserviamo anche che siamo in presenza di posizioni lavorative ad alta percentuale di precarietà e quindi con stipendi bassi. Ciò è evidente in tutti i dati statistici che riportano le variazioni salariali degli ultimi decenni. Tale situazione complessiva è, purtroppo, ben definita con il termine sottoccupazione, perché di questo si tratta.
Siamo in presenza di una “occupazione non produttiva”
Se ne parla anche nel recente volume Verso la piena sottoccupazione (Donzelli Editore,2024) di Brancati e Carboni. Il testo evidenzia come la sottoccupazione sia la tendenza verso cui si sta muovendo il mercato del lavoro in Italia, almeno da due decenni a questa parte, anziché trovare un punto di incontro tra politiche avanzate nel campo del lavoro e politiche industriali orientate alla modernizzazione del sistema e alla riduzione dei vincoli alla crescita basati sul capitale umano. Servirebbe infatti una politica industriale per “buoni lavori”, per esempio, per dare spazio e prospettive a profili professionali medio alti che non possono che originare da un eccellente sistema di istruzione tecnica, prevalentemente terziaria.
Allora, l’affermazione sul tasso record di occupazione è fuorviante e non rappresentativa della realtà. Andrebbe completata aggiungendo che il tasso dell’occupazione in Italia è inferiore a quello di tutti gli altri paesi europei, quindi con un gap negativo che incide sulla produttività, e che abbiamo una percentuale molto elevata di precariato, quindi con stipendi bassi. Ma c’è di più. Se analizzassimo il Costo del lavoro per unità di prodotto (Clup), che è uno dei parametri con cui si confronta la competitività del Paese, osserviamo che da tempo è salito significativamente rispetto alla Germania, Francia e Spagna, portandosi in una fascia pericolosa di valori non competitivi.
Il Clup dipende dal “costo aziendale del personale”, composto dagli stipendi, dai contributi e quindi dalla tassazione. Ma se il Clup è alto e gli stipendi sono bassi, è evidente che siamo in presenza di una “occupazione non produttiva” e quindi non generatrice di prestazioni competitive. Costi elevati indicano, ad una anamnesi immediata, la presenza di inefficienza. A sua volta una “occupazione non produttiva” è riconducibile a malesseri prestazionali nei processi aziendali e quindi nelle attività in essi comprese e, a loro volta, dovuti a molteplici concause. Sono tutti quei fattori che dovrebbero rappresentare il “cruscotto” aziendale da monitorare con continuità, per osservare il complessivo andamento e intervenire con le terapie più appropriate laddove ne fosse necessario. Lo scrive anche Draghi nel suo rapporto. Per mantenere la competitività abbiamo bisogno di incrementare nelle nostre imprese i fattori produttivi e di introdurre l’innovazione.
Serve una buona attività di accountability
Lo stato febbrile di un paziente pluripatologico- e l’economia del nostro Paese ha parecchie patologie– e la conseguente misurazione della febbre, non è esaustivo per indicare sia pur sommariamente lo stato di salute. C’è ben altro da investigare. Anche le polmoniti possono apparire senza sintomi febbrili. E quindi, una occupazione precaria, a bassi salari e poca produttività e quasi in assenza di innovazione, come nel nostro caso, può essere presente anche nelle condizioni del più alto tasso di occupazione del Paese, ma se quest’ultimo è il più basso dei valori dei 27 paesi, allora indica la presenza di una seria patologia. Tra l’altro sottolineando, che questa alta occupazione è poi contrattualizzata con un’alta percentuale di precarietà e retribuita con salari bassi.
È evidente che per occuparsi di questi argomenti occorre un approccio sistemico e non di analisi frammentate. Bisogna sapere leggere con attenzione il complessivo sistema economico e sociale in tutte le sue dimensioni. Non è sufficiente conoscere il tasso di occupazione; la produttività non è fatta dal numero dei lavoratori, di cui una parte potrebbe trovarsi anche in cassa integrazione, ma bensì dalle ore lavorate e dal costo dell’ora lavorata. Ed è anche sconsigliabile “cantare vittoria” prima del tempo, perché si distolgono attenzioni e energie che dovrebbero essere applicate alla risoluzione dei problemi per evitare il loro peggioramento e anche le eventuali ricadute.
Allora, le politiche terapeutiche dei mali che affliggono le nostre imprese industriali possono fare buon uso, per esempio, della creazione di nuove competenze e quindi profili di ruolo, attraverso l’istruzione terziaria degli Its Academy. È forse lo strumento più immediato, e qualora l’offerta formativa fosse quella corretta, anche il più adeguato. Sicuramente dispone di una cifra investita importante di ben 1,6 miliardi di euro. Con questi soldi si possono ottenere importanti risultati. Una valutazione sia pur sommaria fa ipotizzare che il valore creato nell’economia possa essere pari a 2-3 punti percentuali annui di Prodotto interno lordo (PIL). E in ambito occupazionale, il grande disallineamento tra la domanda di tecnici e l’offerta di diplomati, così come indicato da Unioncamere, farebbe supporre una piena e immediata occupazione.
Ma è effettivamente così? Qualche dubbio sorge se leggessimo la pubblicità di una importante ITS Academy, che indica che “l’87% di chi studia in ITS trova lavoro a un anno dal diploma!” Delle due è l’una: o non è vero che mancano i tecnici con le competenze richieste dalle imprese, quest’ultime che dovrebbero aderire alle iniziative degli ITS Academy, oppure i percorsi formativi di alcune ITS Academy che generano occupazione per “l’87% dei frequentanti a un anno dal diploma”, non sono immediatamente coerenti con il grave fabbisogno immediato di competenze di cui si parla. Allora, una buona attività di accountability, oltre a monitorare con efficacia gli interventi in programma, aiuterebbe ad indirizzare gli investimenti fatti, e a misurare il ritorno degli stessi, nella categoria del “debito buono”.
Perito elettronico e laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, è Maestro del Lavoro. Le prime esperienze lavorative sono nel campo dei sistemi di controllo. Nello stesso periodo, per nove anni, è anche docente di elettronica industriale presso un importante istituto tecnico serale. Contemporaneamente inizia la sua attività presso una società di un gruppo tedesco, leader mondiale nella componentistica per l’automazione industriale nonché partner del governo della Germania per la costruzione del modello duale della formazione professionale. Successivamente diventa Direttore Generale e Amministratore Delegato di una nuova società del gruppo che si occupa di consulenza strategica e operativa nelle aziende industriali a cui appartiene una scuola di Industrial Management e una divisione per i sistemi di apprendimento. È stato pioniere delle prime iniziative di formazione applicata superiore nazionali e transnazionali. Ha intrattenuto rapporti con molti istituti tecnici e istituzioni pubbliche ed è stato promotore e attore di iniziative riguardanti l’evoluzione delle professioni tecniche. Ha terminato la sua attività professionale nella posizione di Vice President del gruppo internazionale, per il settore della Global Education, occupandosi dell’interconnessione tra economia e mercato del lavoro per la progettazione e realizzazione di sistemi TVET per governi di Paesi in via di sviluppo.







